MARZO (a cura di Alberto Rezzi)
È un privilegio ospitare nel nostro blog un’intervista a Sandro Campani, scrittore, musicista, cantante e autore, i cui due ultimi romanzi per Einaudi sono stati e continuano a essere per me grande fonte di scoperta e ispirazione. Un viaggio nel suo mondo, nel suo approccio alla scrittura, alla musica e alla creatività…

Partiamo da Il giro del miele, il tuo primo romanzo per Einaudi. Mi ha colpito molto la tua capacità di fermare la scena principale sul dialogo tra due persone in una sola notte, ma attorno a questo nucleo far ruotare tutta la narrazione. Davide e Giampiero fanno i conti con le loro vite e le loro perdite, senza sconti. Come tutti gli altri personaggi del resto. Come sei arrivato a questo libro e a questa scelta?
Il primo nucleo di quello che poi sarebbe diventato Il giro del miele era la storia d’amore disgraziata fra Davide e Silvia. Intorno c’era già tutto – Giampiero innanzitutto, Uliano il padre, Giuliana la sorella; le api, la falegnameria, la lince – ma quello che mancava era una struttura adeguata al racconto: avevo scritto la stesura iniziale in una terza persona quasi neutra, vicina a una voce infantile, con un certo stupore per le cose e per la natura, magari vicina al sentire di Davide. Però non ero riuscito a scendere in fondo ai personaggi, a dar conto delle tensioni che c’erano tra loro. Giulio Mozzi, che aveva letto questa prima versione, da maestro qual è, mi ha fatto questa domanda semplice: – Chi la racconta, questa storia? – Eravamo a Trento, in una trattoria. Sono andato a dormire, ci ho pensato sopra, e ho capito che raccontare in prima persona sarebbe stato più consono al mio modo di far venir fuori certe faccende: intanto, l’interiorità dei personaggi (sembrerebbe paradossale, ma l’opacità del nostro sguardo, il fraintendimento, l’impossibilità di coincidere col cuore di un altro, possono generare un’attrazione verso l’altro, una maggiore profondità d’attenzione per il suo mistero: e così, i vincoli posti dalla prima persona giovano); l’ambiguità dei fatti; quel senso animistico che aleggia in tante mie cose, e che qui è incarnato in special modo dalla lince. Ho capito che certi grumi di storia nella prima stesura restavano irrelati, dipanati solo in superficie, ma se li avessi sottoposti allo sguardo parziale, mutilato, di un narratore in prima, si sarebbe sviluppata una tensione. Si trattava di capire per l’appunto chi racconta: ho scelto la voce più matura, quella che aveva più vita alle spalle e poteva guardare le cose con più comprensione del proprio dolore e di quello degli altri; questa persona era indubbiamente Giampiero. La voce e la visione di Giampiero però non mi bastavano: dovevano essere messe in dialogo con quelle dell’altro personaggio maschile della storia, cioè Davide. Ed ecco che è nata la struttura, e i fatti si sono ridisposti in un ordine diverso da quello lineare, prendendo un movimento fatto di andirivieni e rimescolamenti – come se scavando attorno ai fatti li ripulissimo e li cambiassimo di posto: un passo che mi è più congeniale.
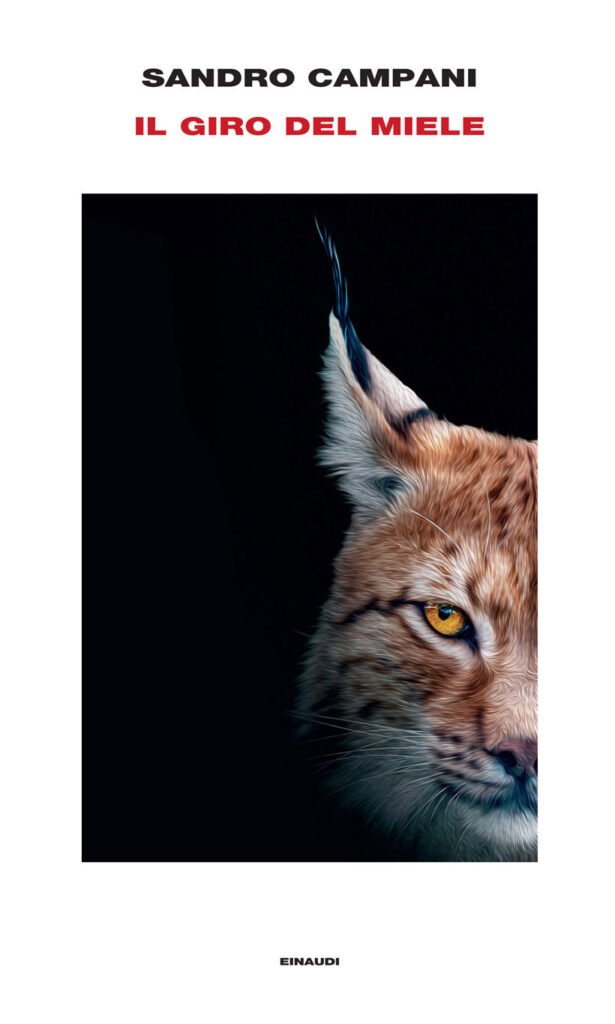
La struttura di una storia, il passo e la voce con cui la racconti, fanno un tutt’uno, è bellissimo quando ti riesce. Ho utilizzato un espediente narrativo canonico (in una notte buia e tempestosa, un personaggio bussa alla porta di un altro. Cosa vorrà?) – e su questa visita inattesa, in una stanza sobria, con due sedie e una bottiglia, ho costruito il duello, sicché a quel punto la storia viaggiava su due binari: quello delle cose raccontate, fra reticenze, mezze verità e nascondimenti, e quello della notte a questo tavolo, con i movimenti di ripulsa e di avvicinamento, di odio e di affetto che come un elastico si tirano e si allentano fra Davide e Giampiero.
Ne I passi nel bosco hai costruito invece un racconto più corale e posto al centro un personaggio “imprendibile”: Luchino. Tra lui e gli altri, la voce del bosco, i suoi segreti, le sue storie. Leggendo si intuisce come il bosco sia a tutti gli effetti un personaggio, non un semplice sfondo. È da qui che parti per costruire le storie degli altri personaggi?
Scrivendo I passi nel bosco ho continuato a esplorare questo gioco delle voci: non sono più due che dialogano (con una terza evocata ma assente, quella di Silvia, che nel Giro del miele parlava, per così dire, attraverso Giampiero) ma sono cinque voci ampie più una sesta breve, quella di Beniamino (il bimbo a cui è assegnato l’epilogo). È diverso però il posizionamento nello spazio della scena che queste voci hanno: dialogano tra di loro solo per contrasto, per giustapposizione; siamo noi che leggiamo a metterle in relazione, perché in realtà sono sei monologhi. Monologhi che hanno come centro un personaggio assente dalla scena, imprendibile come dici tu: Luchino.
La struttura qui è venuta da subito: è una struttura anche questa risaputa, che ho sempre amato, e come esempio inarrivabile e mostruoso avevo forse il più ovvio di tutti, ma anche il più forte – di sicuro, quello che da lettore mi ha segnato fin da piccolo, anche se non ci capivo nulla, ma mi ha veramente aperto la testa: Faulkner, L’urlo e il furore. Questa storia si poteva raccontare solo attraverso varie voci, perché Luchino è un personaggio misterioso, le cui partenze e i cui ritorni vengono caricati dagli altri di un valore esorbitante, che tira in ballo intere le loro esistenze, nel bene nel male – nel rancore, nell’amore, nel desiderio e nel rimpianto, nell’odio persino, e nell’invidia. Luchino è un mistero, e l’unico modo di preservarlo era lasciarlo fuori scena, nel regno dell’incertezza e dell’iperbole, dell’avventura e della diceria. Luchino non parla mai: vive, nella sua imprendibilità e nelle sue contraddizioni, attraverso le voci degli altri.
Quello che dici in merito al bosco è vero. È una cosa che mi porto dietro, e motiva e genera il mio scrivere. Ho sempre amato quegli scrittori che riescono a raccontare attraverso il paesaggio; che non utilizzano il paesaggio come uno sfondo, come una quinta dietro i personaggi, né come un semplice specchio emotivo, ma che lo fanno parlare, narrativamente, e a livello simbolico (non allegorico: simbolico). Pensa a McCarthy, a Faulkner e Steinbeck, a Flannery O’Connor, alla steppa di Cechov, alla Kolyma di Salamov. A Fenoglio, o al Diavolo sulle colline di Pavese: muoversi nel paesaggio significa muoversi nel tempo, e muoversi nel tempo (anche nei ricordi, e nel futuro) è raccontare.
Ne I passi nel bosco ciascun narratore ha il proprio rapporto col paesaggio. Quello di Luisa forse più simile al mio, disilluso ma anche lirico; quello di Oreste più disagiato (nonostante Oreste faccia un lavoro pratico che è collegato al paesaggio, cioè il giardiniere); quello di Antonello è un rapporto meramente pratico, economico – perlomeno nella voce conosciuta di Antonello: la voce del cinico attaccato ai soldi; ma Antonello ha dentro una frattura legata all’amore della sua vita, quello che Luchino gli ha portato via, e questa seconda voce è collegata al bosco in un modo quasi religioso: il rapporto che Antonello ha con una certa quercia biforcuta è anche un omaggio a un altro libro che mi ha segnato la vita, da bambino e poi da adolescente, e anche da adulto non ho mai smesso di rileggere: Al Dio sconosciuto, di Steinbeck, in cui una quercia è il centro della religione pagana personale di un agricoltore che in essa vede lo spirito del padre.
Tecnicamente, dal bosco in questo caso ma in generale dal luogo, dal paesaggio, parto per costruire le mie storie. Dalla visione di un luogo nasce la suggestione di personaggi che possano abitarlo, dalla relazione fra questi nasce una possibile storia. Non mi è dato il percorso inverso.
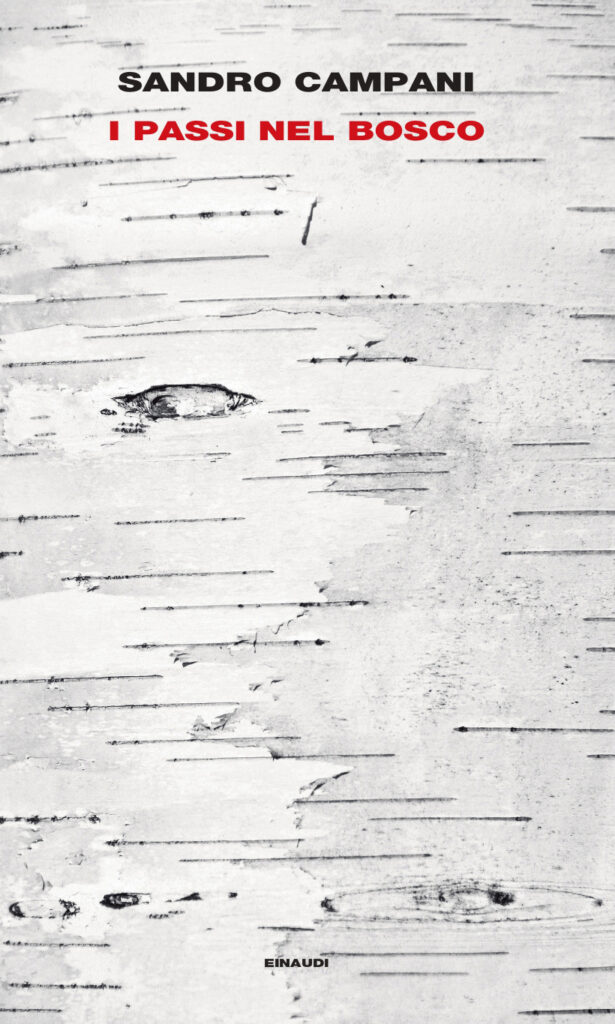
Il rapporto con la tua terra è un elemento fondamentale del tuo immaginario. In che modo è cambiato tra un libro e l’altro e con la maturazione tua e dei tuoi personaggi, alcuni dei quali ritornano, cambiati, nei vari libri?
Sono cresciuto in Appennino, in un posto dove, per forza di cose, essendoci poco (e poca gente) ma tanto spazio, ti abitui a osservare questo spazio, e a percorrerlo con lentezza. Se prendi la bici a otto anni per andare a trovare l’unico coetaneo definibile come amico e devi fare cinque chilometri in salita, lo spazio lo osservi e lo sudi. Poi fin da piccolo sono sempre andato a funghi, la nostra è una famiglia di fungai, uno dei miei fratelli lo fa di mestiere, l’altro fra i suoi tanti mestieri fa il boscaiolo. Sono entrambi più piccoli di me. Io, che sono il primogenito, mi sono sempre sentito inadatto a questi lavori, come un figlio sbagliato – da questo punto di vista, sono colui che interrompe la catena del rapporto con la terra che hanno avuto tutte le generazioni precedenti fino a quella di mio padre, e che i miei fratelli minori proseguono. Quindi, per me, cercare attraverso la scrittura di riavvicinare la mia terra non ha mai significato la presunzione di raccontarla, ma il tentativo di colmare un distacco. Il paradosso è che, senza quel distacco, non potrei scriverne.
Mi rendo conto che questa cosa era già prepotente nelle primissime cose che ho scritto e pubblicato, anche quando non me ne accorgevo ancora. Col tempo, è cresciuta la consapevolezza, e con questa il senso di responsabilità. Il dovere di non barare: il che poi, scrivendo, vuol dire raggiungere l’autenticità attraverso l’artificio.
Ogni volta che leggo un romanzo, un saggio o una raccolta di racconti, provo a immaginarmi che vita l’abbia originato, quali urgenze personali dell’autore l’abbiano portato a maturazione. Di solito come lavori e come vivi il processo di scrittura, dalla fase dell’ideazione all’ultima revisione?
Mentre scrivo mi sento un po’ più attento e consapevole, persino più intelligente di quando non sto scrivendo. In genere sono una persona distratta, imprecisa, piena di buchi in tutto, e la mia memoria latita, per dirla con Paolo Conte: scrivere è l’attività che mi fa assurgere a uno stato di concentrazione, di lucidità e insieme di trasporto, che mi esalta, in un certo senso. Anche suonare: ma nel suonare, ecco, c’è più il trasporto e meno la lucidità.
Difficilmente comincio a lavorare a una storia sapendo cos’è. Ho delle immagini, dei luoghi, delle fascinazioni, cose che non mi vanno via dalla testa ma ancora non riesco a mettere a fuoco. Cominciano a raggrumarsi, le metto in collegamento, e da questi grumi nasce a tentoni una storia: prima dei personaggi, e poi una storia, che è il risultato della relazione fra questi personaggi.
La fase dell’ideazione per me è una tortura. Prima penso di non aver niente da dire; poi penso che quello che ho da dire non sia sensato, né utile né valido; poi comincio a scrivere, e penso che quello che ho da dire mi sfugga, e io non sia in grado di dirlo; poi che non sia abbastanza detto bene. Arrivo alla fine della prima stesura con questa sensazione di vaghezza e di insoddisfazione, di sciatteria e timore addosso. Poi mi metto a rileggere, e mi rendo conto che, anche inconsapevolmente, ho messo giù cose a cui tengo, che posso sviluppare, che posso dire meglio, certo, ma a quel punto sono già coi piedi su un terreno un po’ più solido: nella riscrittura mi sento più a mio agio, anche quando cambio strada o butto via; inizia a essere più divertente, per quanto faticoso. La parte in cui mi diverto proprio, quella in cui riesco a godere della scrittura, è l’editing. Non smetterei mai di editare: intanto è una bellissima forma di lezione; poi, è un momento in cui hai già la rassicurazione di uno sguardo professionale altrui che si è posato su quello che hai fatto e lo ritiene valido, e ti sta accompagnando. Quando alla fine mi rileggo ad alta voce e faccio l’editing degli ammennicoli, riga per riga, sostituendo un aggettivo, tagliando una preposizione, troncando una sillaba perché suona di troppo, quello sì che è veramente un godimento.
La lettura è una componente creativa della scrittura, esattamente come l’ascolto per chi suona. In che modo impasti le pagine di cui ti nutri come lettore con quelle che scrivi? Ricordi alcune opere in particolare che ti sono state di grande ispirazione per i tuoi libri?
Alcuni dei mostri sacri con cui sono cresciuto te li ho già anticipati: a vent’anni il mio pianeta era composto da Stati Uniti e Russia, con le Langhe in mezzo (Pavese e Fenoglio erano praticamente gli unici due italiani che leggevo, con la foga e i pregiudizi dell’adolescenza); poi venne Fitzgerald, poi Flannery O’Connor, poi Conrad, poi alcuni autori incontrati più tardi (Foster Wallace, Cheever, Mordecai Richler, Tobias Wolff, Malamud, Dürrenmatt, Graham Greene) che sono fra quelli che rileggo spesso. Ho iniziato a esplorare altre cose “da grande”: la letteratura italiana, ad esempio. Ho delle lacune gigantesche e scopro in ritardo delle meraviglie che per qualcuno con percorsi diversi dai miei sono scontate. Comunque, l’influenza che i libri altrui hanno mentre scrivi agisce anche su un piano che non è necessariamente quello dell’esempio e dell’imitazione. Blixa Bargeld in un’intervista ha detto che gli Einstürzende Neubauten si sentivano ispirati dalla musica brutta che sentivano in giro: volevano fare quello che gli mancava. Non mi spingo fin lì, però anche ragionare su quel che non ti piace, sul perché non ti piace, ti serve. Poi, mentre scrivi, nel momento in cui sei davvero dentro a quello che stai facendo, con i tuoi personaggi, nel loro mondo, succede che, come attratto da una calamita, tutto quel che leggi e che vedi si raduna per parlare a quel mondo in cui sei. Sicché ci sono cose che non c’entrano col tuo immaginario e con ciò che stai facendo che pure ti insegnano in maniera trasversale, e ti vanno a risolvere dei problemi. Non tanto nello stile, quanto magari in un certo atteggiamento dei personaggi, o nella soluzione ritmica di una certa scena, o nella struttura di un certo capitolo: se non avessi letto o visto proprio quella cosa, magari lontanissima da te, non ci avresti pensato. È molto bello. È un po’ come se tu avessi aperto un canale ricettivo che porta a quello che stai scrivendo, e tutto andasse a confluire lì.
Ecco: ai testi scritti che ti ho detto, bisogna che aggiunga certe cose altrettanto importanti per me: David Lynch prima di tutto; riguardo Twin Peaks e Fuoco cammina con me per intero una volta ogni due anni, mi sa, sicché sarò arrivato alla quindicesima visione e oltre, praticamente ci abito dentro. I film di Atom Egoyan, di Gus Van Sant, di Debra Granik. Dino Risi. E Il tenente Colombo, che è una lezione continua.

Abbiamo accennato alla musica, un’altra dimensione importante della tua creatività. Hai pubblicato diversi album con il tuo gruppo, gli Ismael, di cui sei autore e cantante. Raccontaci un po’ di questa esperienza e in che modo sei riuscito a coniugarla in questi anni con la scrittura.
Gli Ismael sono nati dalle ceneri del gruppo che avevo a vent’anni, e prendeva il nome da Twin Peaks, appunto: The Sycamore Trees. Facemmo tre CD autoprodotti, cantati in inglese; avevamo delle belle idee musicali, ma eravamo molto acerbi e, soprattutto io, deficitari dal punto di vista tecnico. Avemmo il nostro quarto d’ora di celebrità, un po’ di coccole dalle riviste musicali, e ci sciogliemmo quando il cantante andò a stare negli USA, dove abita tutt’ora. Qualche anno dopo mi è tornata voglia di suonare: mentre coi Sycamore Trees scrivevo solo le musiche, con gli Ismael mi è toccato di affrontare i testi in italiano. All’inizio ho fatto molta fatica. Le musiche mi escono con gran facilità, ma con i testi sono di una stitichezza cronica: magari faccio tre musiche in un pomeriggio e poi restano lì addirittura degli anni, continuo a riascoltarmele in macchina, provandoci sopra qualcosa, mentre vado, ce n’è di strada prima di trovare un testo. Accosto, e mi mando un vocale. Nei casi rarissimi in cui testo e musica sono arrivati insieme è stata come una specie di magia, come entrare in un mondo al di là della mia consapevolezza, ancor più inconoscibile di quello che sfioro quando scrivo: la prima cosa che penso in quei casi, riascoltando, è che mi sembra impossibile di averla fatta io quella canzone, e non sarei assolutamente in grado di riprodurre consapevolmente il processo.
Nel primo disco degli Ismael (avventura in cui mi ha accompagnato l’altra chitarrista dei Sycamore Trees, Giulia Manenti) che era principalmente acustico e registrato in maniera ancora un po’ rustica, c’erano alcune canzoni propriamente dette, ma per la maggior parte i testi erano frasi ripetute, bozzetti molto corti, enunciati da una voce timida. La musica, nell’affrontare l’italiano, si era come contratta. In sostanza, il faro di quel disco, al netto delle reminescenze rock, era la Pecora di De Gregori. Dal secondo disco in poi ho cominciato a sciogliermi, le mie canzoni hanno cominciato a diventare molto narrative – specialmente nel secondo e nel quarto disco: canzoni che raccontano storie, e in diversi casi si sono intrecciate con le storie dei miei romanzi: La visita della lince e Crostata di mirtilli sono stati pezzi degli Ismael, prima che pagine del Giro del Miele. E i primi appunti per I passi nel bosco li ho presi andando a capo, in rima: i personaggi hanno cominciato a parlare nelle canzoni del quarto disco.

Anche musicalmente via via ci siamo un po’ sgranchiti, è arrivato Piwy, che oltre a essere un bravo saxofonista ha orecchio per l’arrangiamento, e oltre ai primi appoggi per la scrittura in italiano (i miei tre o quattro numi giganteschi a cui non oso accostarmi neanche col pensiero: De Gregori, Ivan Graziani, Paolo Conte, Giovanni Lindo Ferretti) siamo riusciti pian piano a recuperare le influenze musicali che ci avevano formato: i Joy Division, i Bad Seeds, i Low, i Built to spill, i Massimo Volume… Ma se devo dire in assoluto il gruppo che più mi ha influenzato, da sempre, che non smetto mai di riascoltare, e che mi sembra di sentire sottotraccia in diverse cose che ho fatto, dico i Thin White Rope. Quell’amalgama di blues, di country, di psichedelia e new wave, di rock con l’attitudine sbragata, una splendida oscurità melmosa.
Dopodiché, nonostante fossimo maturati, anche tecnicamente, adesso gli Ismael sono fermi, nel senso che non suoniamo più. Per due motivi: il primo è che mi sembra di aver fatto con le canzoni, per il mio momento attuale, il massimo che potevo fare; se dovessi comporre una canzone oggi, mi verrebbero cose che ho già fatto, e quindi non trovo lo stimolo di sperimentazione necessario – anche perché col passare del tempo sento che il mio ascolto si è atrofizzato, invece che aprirsi, e quindi mi è definitivamente chiaro che non sarò e non avrei mai dovuto essere un musicista. Vado orgoglioso di quello che abbiamo fatto, ma per ora ci fermiamo qui, anche perché il tempo e gli sforzi necessari a continuare sono del tutto sproporzionati alla mia vita attuale, e anche a quella degli altri ismaeliti.
Ho un lavoro che mi paga uno stipendio e verso il quale ho delle responsabilità (faccio il grafico per la ceramica a Sassuolo); la scrittura intanto si è presa sempre più spazio, e quello che rimane è poco. Continuare a sbattersi ogni settimana in sala prove, a provare e riprovare per quei pochi concerti che si fanno per gli amici, quasi come sopportando un peso, non ha un gran senso. Non c’è neanche il tempo fisico. Proprio perché siamo cresciuti, e pensiamo che ciò che abbiamo fatto abbia una qualità che dobbiamo rispettare: per portarlo in giro dal vivo, non essendo dei mostri, serve un impegno spropositato rispetto alla soddisfazione che se ne ricava. Io poi ho sempre vissuto malissimo il palco. Tanto mi piace leggere in pubblico ad alta voce, parlare con i lettori alla presentazioni, tanto mi angoscia salire su un palco: mi si chiude lo stomaco, divento irascibile… Dopo i primi due pezzi mi sciolgo e riesco anche a godermela, qualche volta, ma è comunque una tensione che mi strema. Ne accumulo tanta che poi, quand’è finita, è come aver passato un esame difficilissimo e volteggiare stordito a mezz’aria, finisce che mi ubriaco e mi ripiglio due giorni dopo. Penso che a respingermi sia la mole di attenzioni tecniche che occorre. Alla tastiera del computer io posso tranquillamente battere i miei romanzi con due dita impacciate, nessuno mi chiede di essere un bravo dattilografo per apprezzare quello che scrivo, mentre per usare una pedaliera degli effetti, saper fare i suoni su un palco e cantare suonando mi servono capacità tecniche che non ho pazienza nell’esercitare, e questo per me fa la differenza fra le due faccende.
Mi piacerebbe scrivere ancora testi per altri (come ho fatto qualche anno fa per “Il giardino che non vedi” degli Üstmamo’, ed è stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita: me l’avessero predetto da fan adolescente, sarei svenuto). Oppure anche avere un progetto in cui canto e basta: magari compongo, ma poi suona qualcun altro; mi sento molto più libero se devo badare soltanto alla voce. Quand’è capitato, con progetti paralleli, sul palco mi sono sentito bene, mi sono divertito, il concerto non mi spaventava. Mi piacerebbe, invecchiando, avere un giorno la maturità per fare qualcosa di diverso, sperimentare altre strade, con dei musicisti attorno, ed essere libero nel canto. Chissà, il mio canto del cigno alla Johnny Cash.
Tra le cose che mi sono piaciute molto negli ultimi anni, e che sono entrate più in profondità senza fermarsi alle mie orecchie sempre più distratte, ti dico Anna Von Hausswolf, Sleaford Mods, Fountaines DC.
Hai esordito nella narrativa diversi anni fa. Se ti guardi indietro, cosa conservi di quel ragazzo che pubblicava il suo primo romanzo e cosa invece è cambiato molto? Qual è il tuo desiderio oggi come scrittore?
Se guardo a quel ragazzo innanzitutto sono contento di vedere che fin dall’inizio il mio immaginario aveva una forma, più immatura allora e inconsapevole, sicuramente, ma non devo rinnegare nulla di quello che ho pubblicato. I primi due racconti che ho scritto per davvero, poi finiti ne “Il paese del Magnano”, sono del 1999: uno fu scritto e mai più toccato, uno rimaneggiato infinite volte fino alla pubblicazione, nel 2010. Eppure il mio mondo era già tutto lì: c’era la Luisa del bar, c’erano il lago e Kon-Tiki, Oreste e Luchino (col suo nome di battesimo, Vittorio). L’anno prossimo compiranno 25 anni! In tutto questo tempo ho acquistato consapevolezza, sia della mia tecnica che dei miei limiti, e ho perso incoscienza. Mi ritengo fortunato di aver potuto lavorare in una maniera così libera, sentendo intorno l’affetto di chi mi pubblicava, curando ogni cosa che ho scritto nel miglior modo possibile. Certo, ci sono cose che tornerei volentieri a rielaborare: specialmente il libro che uscì per Rizzoli nel 2013 dopo un lavoro di otto anni e che fu veramente una battaglia con la forma romanzo, il primo tentativo di tirare la mia lingua in una struttura romanzesca ampia, tentativo non del tutto riuscito. Non avevo le spalle larghe abbastanza. Dovesse mai avere una seconda vita, ci rimetterei le mani, e sarebbe anche divertente. Mario, che è un mio personaggio feticcio, uno senza il quale non mi imbarco in una storia lunga, è nato là. Era la sua parte da protagonista, mi dispiace che per colpa mia l’abbia steccata.
Il mio più grande rischio, che sono ben strutturato per evitare, è quello di sostituire il mestiere alla voglia, di cominciare a farmi il verso e di adagiarmi sulla formula che mi viene bene.
La mia più grande paura non cambia mai, è la solita ogni volta che comincio qualcosa di nuovo: quella di non saper più mettere giù una riga decente, e di non aver niente da dire. È una paura che non cala mai d’intensità: più consapevolezza non significa più sicurezza. In quello, riparti ogni volta da zero.
La mia tranquillità è sapere bene che nel momento in cui non sentirò più la spinta, la smania istintiva di scrivere, non mi forzerò. Penso che mi accorgerò di aver detto quello che avevo da dire nei modi in cui volevo dirlo, e smetterò. Dopodiché si tratterà di trovare un’altra cosa che mi dia l’illusione di avere un senso al mondo, a parte lavorare, ma quello penso che sia un problema di tutti. Magari ricomincerò a studiare, e prenderò una laurea in geologia.

Immagino, e da lettore spero, che tu sia alle prese con nuove idee e una nuova storia da portare sulla pagina. Puoi svelarci qualcosa?
In autunno se tutto va bene uscirà, sempre per Einaudi, un libro di cui sto facendo l’editing; non è un romanzo, ma un testo che racconta le camminate per l’Appennino insieme a mio fratello, che come ti dicevo fa il fungaio e il tartufaio di professione; una camminata attraverso la giornata e le stagioni, e a ritroso nelle nostre vite fino a ritrovare i due bambini, i due fratelli che siamo stati, gli uomini che ci siamo avviati a essere seguendo nel bosco nostro padre.
Poi ho cominciato a scrivere il romanzo nuovo, con tutti i dubbi e le incertezze di cui ti parlavo, perché avrà di nuovo una forma diversa dagli altri ed è una forma che mi mette in crisi; ma proprio per questo mi sta appassionando, perché se un testo non ti pone di fronte dei problemi più grandi di quelli che pensi di poter risolvere fai davvero fatica a restarci attaccato per anni, finisce l’interesse e quindi il gusto.
